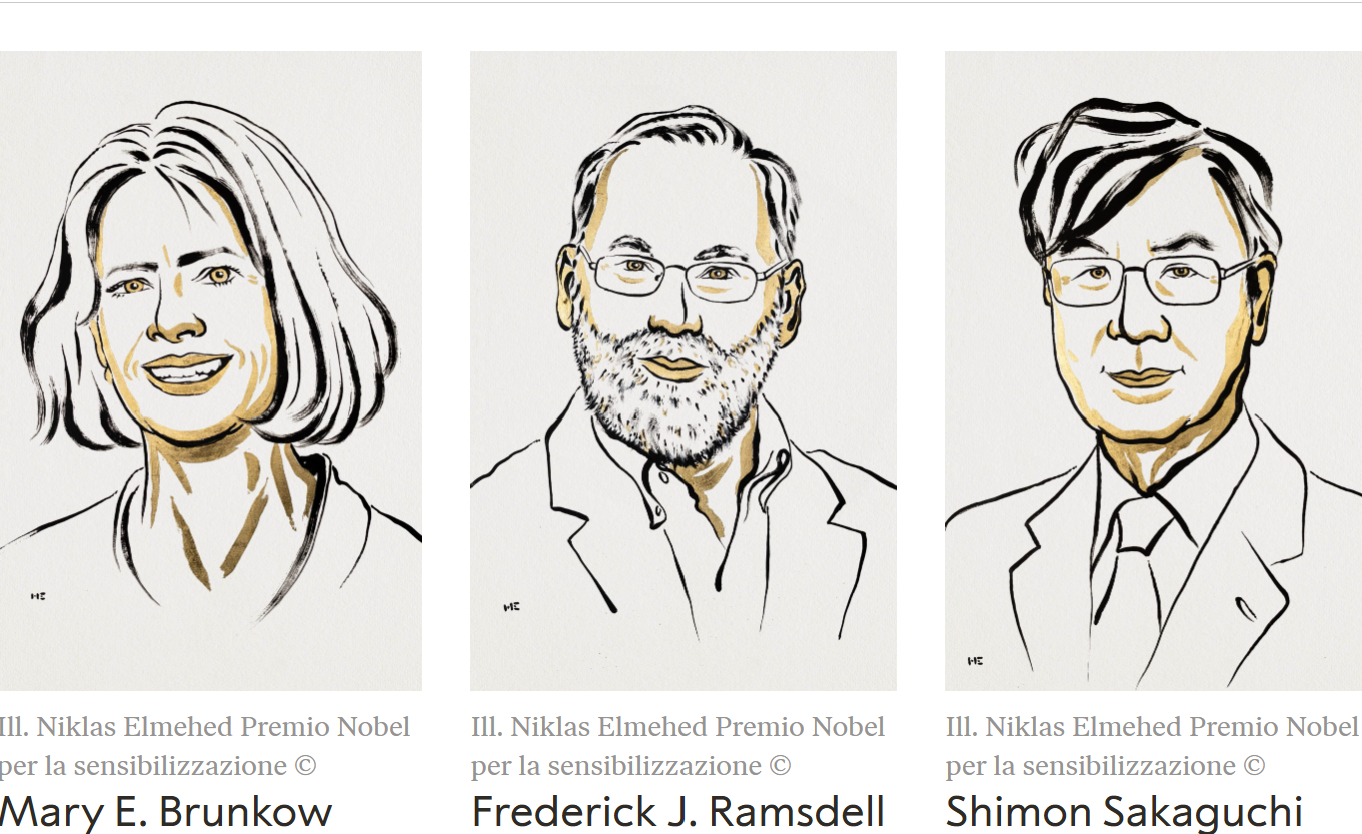
Il sistema immunitario è un vero capolavoro evolutivo: senza di esso, nessun essere umano potrebbe sopravvivere. È un esercito invisibile, programmato per riconoscere e neutralizzare ogni potenziale minaccia. Una delle sue meraviglie è la capacità di distinguere con precisione chirurgica ciò che è “altro” – come virus, batteri, cellule tumorali – da ciò che appartiene al corpo stesso. Ma i nemici non sono sempre riconoscibili: si mascherano, cambiano sembianze, imitano le cellule sane per confondere le difese. Per decenni, gli scienziati hanno creduto che il segreto di questa discriminazione risiedesse interamente nella tolleranza immunologica centrale, un processo di selezione che avviene nel timo e che elimina le cellule immunitarie “ribelli”. Poi, le ricerche di tre studiosi, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, hanno cambiato la prospettiva. Le loro scoperte, premiate con il Nobel per la Medicina e la Fisiologia 2025, hanno svelato l’esistenza di un secondo livello di controllo, la tolleranza immunologica periferica, una sorta di sistema di sicurezza diffuso che impedisce alle nostre difese di rivolgersi contro l’organismo stesso. Da queste intuizioni è nato un nuovo campo di ricerca, che oggi apre la strada a terapie innovative per le malattie autoimmuni, per il cancro e per prevenire il rigetto dei trapianti.
Nel nostro sistema immunitario c’è un servizio di “security” che vigila perché le cellule non commettano errori fatali attaccando i propri tessuti. Queste guardie sono le cellule T regolatrici (T-reg). A scoprirle è stato il giapponese Shimon Sakaguchi, professore emerito all’Università di Osaka, che negli anni ’80, andando controcorrente, intuì che doveva esistere una popolazione di linfociti capace di “calmare” gli altri e mantenerli sotto controllo. All’epoca si riteneva che la tolleranza immunitaria si sviluppasse esclusivamente nel timo, dove le cellule potenzialmente dannose venivano eliminate: era la cosiddetta ‘tolleranza centrale‘. Ma Sakaguchi comprese che esisteva anche una tolleranza periferica, mantenuta da cellule T speciali, che impedivano agli “errori” sfuggiti al controllo del timo di scatenare malattie autoimmuni. Nel 1995 pubblicò la prova definitiva: le cellule T regolatrici si distinguevano per la presenza sulla loro superficie di due proteine, CD4 e CD25.
Il secondo capitolo di questa storia comincia negli Stati Uniti, in un laboratorio di ricerca nato nel contesto del Progetto Manhattan. Negli anni ’40, alcuni topi maschi con una mutazione genetica – soprannominati scurfy – nascevano con pelle squamosa, milza ingrossata e un sistema immunitario iperattivo che distruggeva i loro stessi tessuti. Negli anni ’90, con gli strumenti della genetica molecolare più avanzati, Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell – entrambi impegnati nella biotech Celltech Chiroscience – decisero di scoprire quale gene fosse responsabile di questa anomalia. Dopo un lavoro titanico, riuscirono a individuare il colpevole: Foxp3, localizzato sul cromosoma X. Brunkow e Ramsdell capirono che mutazioni dello stesso gene nell’uomo causavano una rara e devastante malattia autoimmune infantile, la sindrome IPEX. Nel 2001 pubblicarono su Nature Genetics i risultati che dimostravano il ruolo cruciale di Foxp3 nello sviluppo delle cellule T regolatrici. Due anni più tardi, Sakaguchi completò il puzzle: Foxp3 è il “fattore di trascrizione” che guida la formazione e la funzione delle T-reg, le cellule incaricate di mantenere l’equilibrio immunologico.
Le cellule T sono le protagoniste di questa straordinaria rete di protezione. Alcune, le T helper, pattugliano costantemente il corpo e segnalano la presenza di un’infezione. Altre, le T killer, eliminano le cellule infette o tumorali. Tutte sono dotate di recettori specializzati che funzionano come sensori molecolari, capaci di distinguere i segnali di pericolo. Ma questo sistema, tanto preciso quanto potente, può trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Se non viene regolato, può scatenare l’autoimmunità: l’organismo attacca se stesso. Le cellule T regolatrici sono la chiave di questo equilibrio: ne garantiscono la “tolleranza” e impediscono la catastrofe.
Le scoperte dei tre Nobel hanno aperto la strada a un intero filone di ricerca oggi in pieno fermento. In ambito oncologico, i ricercatori cercano di bloccare le T-reg per permettere al sistema immunitario di riconoscere e distruggere i tumori. Nelle malattie autoimmuni, invece, l’obiettivo è opposto: stimolare o espandere le T-reg per ripristinare la tolleranza e calmare un sistema immunitario iperattivo. Tra le strategie sperimentali ci sono la somministrazione di interleuchina-2 – che ne favorisce la proliferazione – e l’uso di linfociti T regolatori autologhi, isolati dal paziente, moltiplicati in laboratorio e poi reintrodotti per rafforzare il controllo sull’autoimmunità o prevenire il rigetto dopo un trapianto.
“Questo premio rappresenta un riconoscimento molto importante per l’immunologia e, in particolare, per la reumatologia – commenta Maria Antonietta D’Agostino, ordinaria di Reumatologia all’Università Cattolica e direttrice della UOC di Reumatologia del Policlinico Gemelli IRCCS -. Le scoperte sulla tolleranza immunitaria e sul gene FOXP3 hanno rivoluzionato la comprensione dell’equilibrio immunologico e dell’autoimmunità. In reumatologia – aggiunge – abbiamo studiato come un difetto delle cellule T-reg possa contribuire alla patogenesi di malattie come l’artrite reumatoide, il lupus, la sindrome di Sjögren e le connettiviti indifferenziate. La possibilità di modulare queste cellule rappresenta oggi una delle frontiere terapeutiche più promettenti”.
Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato